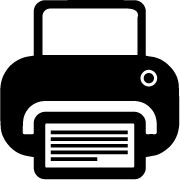1. Il contesto di riferimento. Il fenomeno della povertà educativa in Italia
La povertà educativa minorile rimane un fenomeno complesso e multidimensionale. Non è solo correlata alle difficoltà economiche, ma si estende anche alla povertà di relazioni, all’isolamento, alla scarsa attenzione verso salute e alimentazione, e alla carenza di servizi e opportunità educative e di apprendimento non formale. La povertà educativa priva bambini e adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, scoprire le proprie capacità, sviluppare competenze, coltivare aspirazioni. Si tratta di un fenomeno che impatta sulla dimensione emotiva, sociale e relazionale, creando le condizioni per l’ingresso precoce nel mercato del lavoro, per l’abbandono e la dispersione scolastica (nelle loro diverse manifestazioni) e per fenomeni di bullismo e violenza nelle relazioni tra pari.
Il rapporto ISTAT 2024 ha evidenziato livelli di povertà assoluta tra i bambini e gli adolescenti senza precedenti nell’ultimo decennio: 1,3 milioni di minorenni vivono in condizioni di povertà assoluta, con un’incidenza del 14% (il valore più alto registrato dal 2014). Nonostante l’ampia diffusione del fenomeno, persistono significativi divari geografici e sociali. L’incidenza della povertà minorile raggiunge il suo apice nel Mezzogiorno (15,9%), seguito dal Centro (13,1%) e dal Nord (12,9%). I tassi più elevati si riscontrano tra i bambini e i ragazzi di 4-6 anni (14,8%) e 7 –13 anni (14,5%), superando la media nazionale anche nella fascia 0-3 anni (13,4%) e 14-17 anni (12,7%). Le famiglie con figli minori mostrano un’incidenza di povertà assoluta significativamente più alta (12,0%) rispetto a quelle con anziani (6,4%).
Per i bambini e i ragazzi, la povertà assoluta si intreccia spesso con disuguaglianze nell’accesso all’istruzione e a percorsi educativi di qualità. Fin dalla prima infanzia, queste disparità influenzano il futuro di intere generazioni, condizionando le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, la mobilità sociale e la capacità di mantenere buone condizioni di salute attraverso una consapevole prevenzione e adeguata cura.
Alle disuguaglianze appena descritte, si somma spesso una narrazione estremamente severa e allo stesso tempo semplicistica dei comportamenti e delle caratteristiche di ragazzi e ragazze. La difficoltà di dialogo e comprensione reciproca tra generazioni diverse è uno dei dati emersi con l’indagine demoscopica promossa da Con i Bambini nell’ottobre 2024, nell’ambito della campagna Non Sono Emergenza, in collaborazione con l’Istituto Demopolis. L’indagine evidenzia come il 54% degli adolescenti e il 45% dei genitori percepiscano una mancanza di comprensione da parte degli adulti verso i ragazzi. Questo divario generazionale sottolinea l’urgenza di iniziative che promuovano il dialogo e la comprensione reciproca.